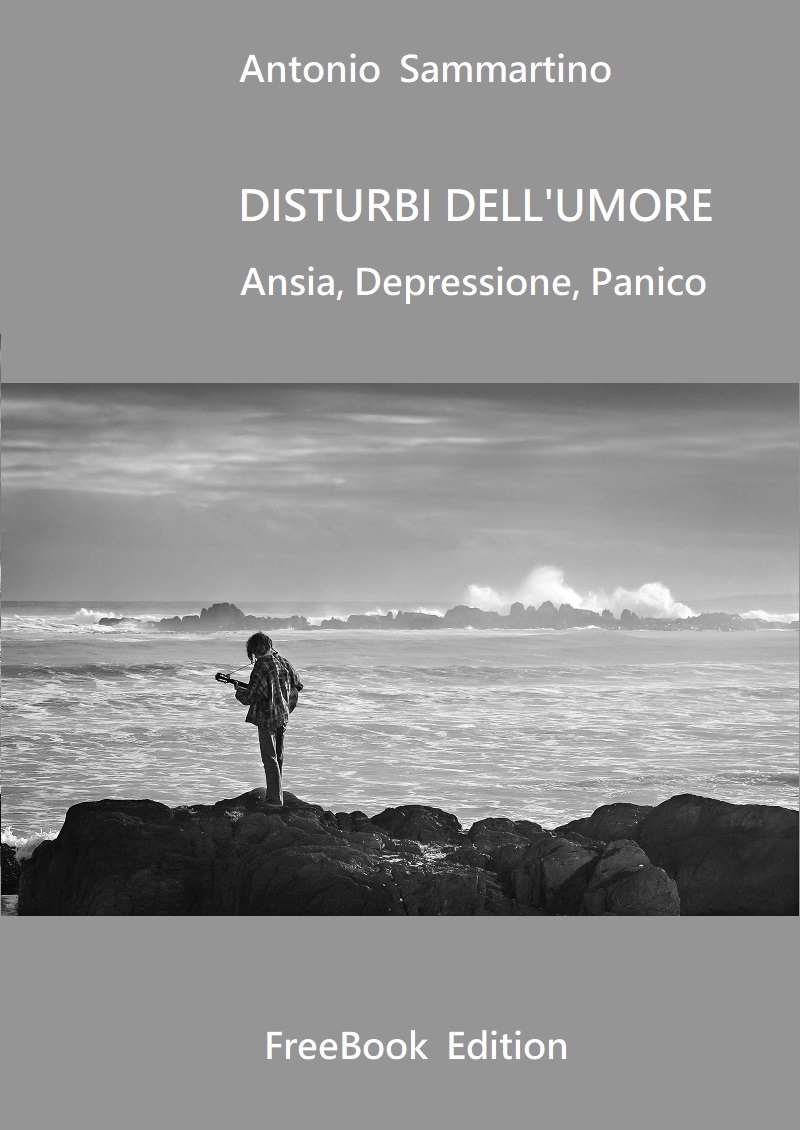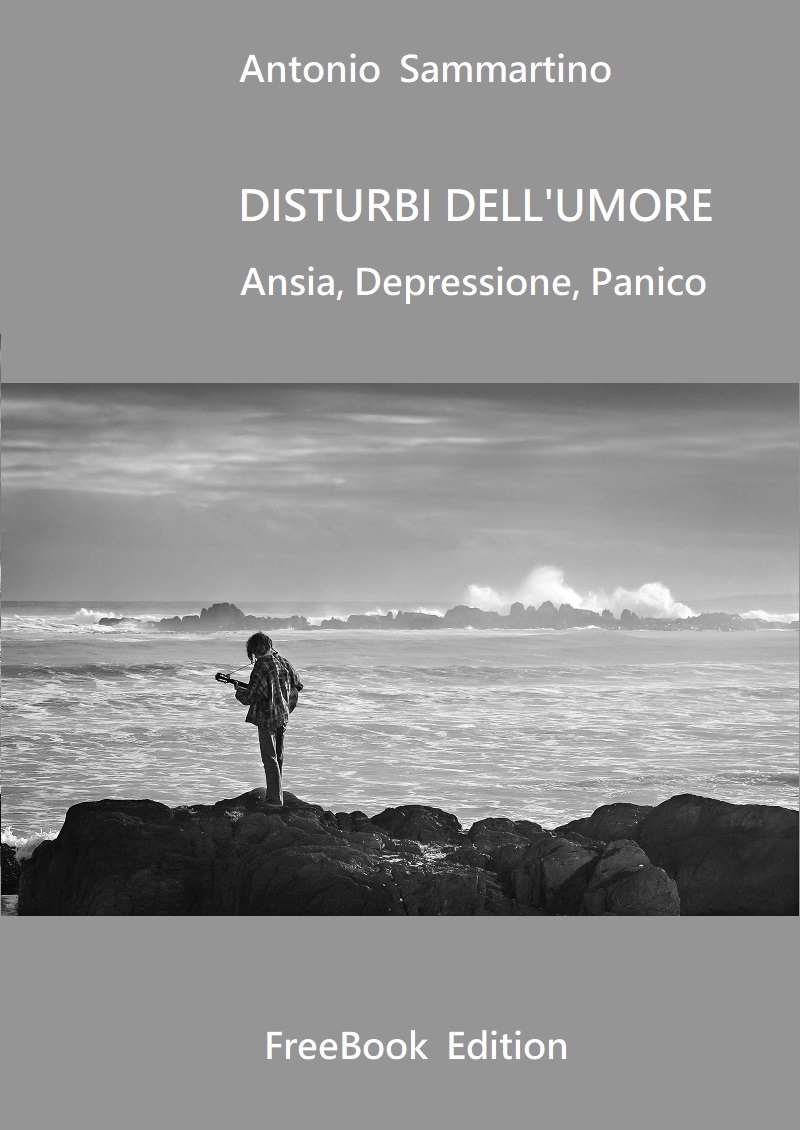Il Pensiero di Franco Basaglia
Il Pensiero di Franco Basaglia
di Antonio Sammartino
25/09/2016
La disinformazione mi aveva indotto a credere che la chiusura dei manicomi fosse stato un grave errore, ma nel leggere il pensiero e la vita di Franco Basaglia, ho acquisito una diversa consapevolezza sulla natura e sulla eziologia dei disturbi mentali.
Nel film sulla vita e il pensiero di Basaglia, mi ha particolarmente colpito la scena in cui il folle, il più folle di tutti viene restituito alla ragione, semplicemente entrando nel suo mondo, convincendolo che la realtà, poteva essere diversa da quello che la sua mente era stata costretta ad immaginare e che la follia non esiste, in quanto tale, ma è semplicemente il prodotto di una società che ha smarrito il senso dell’umanità.
L’essenza dei disturbi mentali e delle turbe psicologiche, spesso non sono da considerare una malattia, ma il risultato di una inadeguata educazione genitoriale e di una lenta e superficiale gestione sociale ed istituzionale dei conflitti.
Basaglia scrive, non so che cosa sia la follia, può essere tutto o niente, ma in ogni caso è una condizione umana.
In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece questa società riconosce la follia come parte della ragione e la riduce alla ragione nel momento in cui esiste una scienza che si incarica di eliminarla. Il manicomio ha la sua ragione di essere, perché fa diventare razionale l'irrazionale. Quando qualcuno è folle ed entra in un manicomio, smette di essere folle per trasformarsi in malato. Diventa razionale in quanto malato. Il problema è come sciogliere questo nodo, superare la follia istituzionale e riconoscere la follia là dove essa ha origine e cioè nella vita.
Per poter veramente affrontare la malattia, dovremmo poterla incontrare fuori dalle istituzioni, intendendo con ciò non soltanto fuori dall'istituzione psichiatrica, ma fuori da ogni altra istituzione la cui funzione è di etichettare, codificare e fissare in ruoli congelati coloro che vi appartengono. Ma esiste veramente un fuori sul quale e dal quale si possa agire prima che le istituzioni ci distruggano?
Dato il livello ridottissimo delle nostre conoscenze nel campo della malattia mentale (in particolare la schizofrenia, di cui conosciamo le diverse modalità di espressione, ma quasi nulla di ciò che riguarda l'eziologia), non possiamo continuare ad accantonare i malati in attesa di raggiungere una più approfondita comprensione di ciò di cui soffrono, aumentandone la sofferenza attraverso la reclusione e la segregazione. Tentiamo invece di accantonare la malattia come vuota definizione, cercando di creare una possibilità di vita e di comunicazione, tale da consentire insieme l'affiorare e il liberarsi di elementi in grado di darci qualche indicazione per l'indagine futura.
Per me, che si parli di psicologo o di schizofrenico, di maniaco o di psichiatra è la medesima cosa: sono tanti i ruoli, all'interno di un manicomio, che non si sa più chi è il sano o il malato. Una delle condizioni del nostro lavoro fu che la nostra unione non scaturiva dalla tecnicizzazione, ma dalla finalità politica che univa tutti. Essere psicologo, psichiatra, terapeuta occupazionale, ecc. ed essere internato era la medesima cosa perché, quando ci univamo in assemblea per discutere, tutti cercavano di dare il proprio contributo per un cambiamento. Noi capimmo, per esempio, che un folle era molto più terapeuta di uno psichiatra.
Dal momento in cui oltrepassa il muro dell'internamento, il malato entra in una nuova dimensione di vuoto emozionale, viene immesso in uno spazio che, originariamente nato per renderlo inoffensivo ed insieme curarlo, appare in pratica come un luogo paradossalmente costruito per il completo annientamento della sua individualità, come luogo della sua totale oggettivazione. Se la malattia mentale è alla sua stessa origine, perdita dell'individualità, della libertà. Nel manicomio il malato non trova altro che il luogo dove sarà definitivamente perduto, reso oggetto della malattia e del ritmo dell'internamento. L'assenza di ogni progetto, la perdita del futuro, l'essere costantemente in balia degli altri senza la minima spinta personale, l'aver scandita e organizzata la propria giornata su tempi dettati solo da esigenze organizzative che, proprio in quanto tali, non possono tenere conto del singolo individuo e delle particolari circostanze di ognuno.
È nel silenzio di questi sguardi che egli si sente posseduto, perduto nel suo corpo, alienato, ristretto nelle sue strutture temporali, impedito di ogni coscienza intenzionale. Egli non ha più in sé alcun intervallo: non c'è distanza fra lui e lo sguardo d'altri, egli è oggetto per altri tanto da arrivare ad essere una composizione a più piani di sé posseduto. Il corpo, affinché sia vissuto è dunque nella relazione di una particolare distanza dagli altri, distanza che può essere annullata o aumentata a seconda della nostra capacità di opporsi. Noi desideriamo che il nostro corpo sia rispettato; tracciamo dei limiti che corrispondono alle nostre esigenze.
Una favola orientale racconta di un uomo cui strisciò in bocca, mentre dormiva, un serpente. Il serpente gli scivolò nello stomaco e vi si stabilì e di là impose all'uomo la sua volontà, così da privarlo della libertà. L'uomo era alla mercé del serpente: non apparteneva più a sé stesso. Finché un mattino l'uomo sentì che il serpente se n'era andato e lui era di nuovo libero. Ma si accorse di non saper cosa fare della sua libertà: "Nel lungo periodo del dominio assoluto del serpente egli si era talmente abituato a sottomettere la propria volontà e i suoi desideri a quelli del serpente. Aveva perso la capacità di desiderare, di tendere a qualcosa, di agire autonomamente. In luogo della libertà aveva trovato il vuoto, perché la sua nuova essenza acquistata nella cattività se ne era andata insieme col serpente e a lui non restava che riconquistare a poco a poco il precedente contenuto umano della sua vita.
Il malato mentale, ricoverato e distrutto nei manicomi, non si rivela soltanto l'oggetto della violenza di un'istituzione deputata a difendere i sani dalla follia; né soltanto l'oggetto della violenza di una società che rifiuta la malattia mentale; ma è insieme, il povero, il diseredato che, proprio in quanto privo di forza contrattuale da opporre a queste violenze, cade definitivamente in balia dell'istituto deputato a controllarlo.
Di fronte a questa presa di coscienza, ogni discorso puramente tecnico si ferma. Che significato può avere costruire una nuova ideologia scientifica in campo psichiatrico se, esaminando la malattia, si continua a cozzare contro il carattere classista della scienza che dovrebbe studiarla e guarirla?
L'irrecuperabilità del malato è spesso implicita nella natura del luogo che lo ospita. Ma questa natura non dipende direttamente dalla malattia. La recuperabilità ha un prezzo, spesso molto alto, ed è quindi un fatto economico-sociale più che tecnico-scientifico.
Quando entrai per la prima volta in una prigione, ero studente in medicina. Lottavo contro il fascismo e fui incarcerato. Mi ricordo della situazione allucinante che mi trovai a vivere. Era l'ora in cui venivano portati fuori i buglioli dalle varie celle. Vi era un odore terribile, un odore di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. Quattro o cinque anni dopo la laurea, divenni direttore di un manicomio e quando entrai là per la prima volta, avvertii quella medesima sensazione.
Non vi era l'odore di merda, ma vi era un odore simbolico di merda. Mi trovai in una situazione analoga, una intenzione ferma di distruggere quella istituzione. Non era un problema personale, era la certezza che l'istituzione era completamente assurda, che serviva solamente allo psichiatra che lì lavorava per percepire lo stipendio alla fine del mese.
Abbiamo dimostrato che l'impossibile può diventare possibile. Dieci, quindici, venti anni addietro era impensabile che il manicomio potesse essere distrutto.
Abbiamo dimostrato che si può assistere il folle in un modo diverso. Non credo che essere riusciti a condurre una azione come la nostra, sia una vittoria definitiva. L'importante è sapere ciò che si può fare. Nella nostra debolezza e in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere. È il potere che vince sempre; noi possiamo al massimo convincere. Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo, cioè determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare.
Il primo contatto con la realtà manicomiale ha subito evidenziato che l'internato, anziché apparire come un malato, risulta essere l'oggetto di una violenza istituzionale che agiva a tutti i livelli. Il livello di degradazione, oggettivazione, annientamento totale in cui si presenta, non è l'espressione pura di uno stato morboso, quanto piuttosto il prodotto dell'azione distruttiva di un istituto, la cui finalità era la tutela dei sani nei confronti della follia.
A Trieste gli operatori sono stati condizionati a valorizzare e convertire le risorse interne (all'ospedale psichiatrico) verso il fuori. Ci si poteva liberare dal manicomio solo a patto di liberare i pazienti. In tal modo il superamento dell'ospedale psichiatrico è diventato possibile per ciascuno a misura di creare, nelle zone e nei rioni della città, soluzioni alternative e servizi decentrati, senza smarrirsi in velleitarie ideologie del territorio come negazione dell'identità di provenienza.
Noi abbiamo compiuto un'azione di violenza nei confronti della comunità, contro la falsa coscienza e l'ideologia dominante.
L’individuo da sempre ha l’impulso a voler dominare l'altro. E’ naturale che sia così, tuttavia diventa innaturale quando si istituzionalizza questo fenomeno oppressivo, quando c'è un'organizzazione che, approfittando dei problemi contraddittori, crea un circuito di controllo per distruggere la contraddizione. Noi rifiutiamo questo discorso. Noi diciamo di affrontare la vita e affrontando la vita noi pensiamo di fare la prevenzione e quindi di fare il nostro mestiere di infermieri, sanitari e di medici.
Non voglio con questo dire che la malattia non esiste, ma che noi produciamo una sintomatologia, il modo di esprimersi della malattia, a seconda del modo col quale pensiamo di gestirla, perché la malattia si costruisce e si esprime sempre a immagine delle misure che si adottano per affrontarla. Il medico diventa gestore dei sintomi e crea un'ideologia su cui poi il manicomio si edifica e si sostiene. Solo così egli può dominare e reprimere le contraddizioni che la malattia esprime.
La follia non viene mai ascoltata per ciò che dice o che vorrebbe dire.
La malattia che entra in queste istituzioni è quindi sempre più lontana dalla follia come esperienza tragica del mondo, come rapporto di un io con una trascendenza che lo sovrasta, o dalla follia come mostruosità e come delitto: si tratta sempre più dell'esperienza tragica di un corpo con la miseria della sua vita e con l'impossibilità di viverla e di esprimere un margine di partecipazione soggettiva.
Ci sono sempre falsi profeti. Ma nel caso della psichiatria è la profezia stessa ad essere falsa, nel suo impedire, con lo schema delle definizioni e classificazioni dei comportamenti e con la violenza con cui li reprime, la comprensione della sofferenza, delle sue origini, del suo rapporto con la realtà della vita e con la possibilità di espressione che l'uomo in essa trova o non trova.